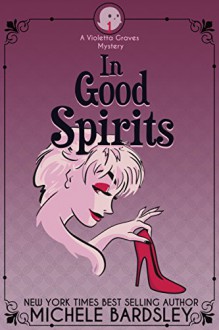Scrive Manganelli nella nota finale: “Se Isherwood scrivesse musica, la sua predilezione ha qualcosa di infantile andrebbe ai fiati: romanzi per oboe, clarinetto, per corno di bassetto. Il corno di bassetto è aereo di quella ariosità serale e boschiva che s’accompagna ad una solitudine insieme pittoresca e irreparabile; un precario sorriso custodisce una delicata risonanza, l’allucinazione dell’eco, una sonorità pensosa, e insieme elegante; la sonorità delicata di una angoscia ostinata ma inafferrabile; l’imprecisa, cattivante angoscia dell’esistenza.”
Londra, anni Trenta.
Chatsworth sogna di realizzare una Tosca scritta da Maugham, con Greta Garbo come protagonista, invece è alle prese con La violetta del Prater. A dirigerlo è il regista ebreo-tedesco Friedrich Bergmann, sceneggiatore il giovane e promettente scrittore Christopher Isherwood.
Si lavora in un clima di esaltazione, di entusiasmo, ma in Europa incombe la catastrofe. A Berlino è in corso il processo per l’incendio del Reichstag; in Austria gli scontri con le masse operaie sono aspri, seguono arresti, condanne, uccisioni. Gli inglesi non vogliono credere. Non ancora. Meglio illudersi che non accadrà. Meglio non pensare allo scoppio di una guerra europea. Meglio vivere nell’inconsistenza della finzione.
“Questo rispettabile ombrello è la bacchetta magica con la quale l’inglese cercherà di fare scomparire Hitler. Quando poi Hitler rifiuterà di scomparire, allora l’inglese aprirà il suo ombrello e dirà: “Dopo tutto, che può farmi un po’ di pioggia?”. Ma la pioggia sarà una pioggia di bombe e di sangue. L’ombrello non è a prova di bomba”.
Solo Bergmann pare inquieto. Sente la guerra avvicinarsi. L’Austria, dove ha lasciato moglie e figlia, non è più sicura.
E mentre fra le macchine dell’illusione volteggia la leggerezza, si scivola, dolcemente, verso il baratro della follia nazista.
La favola bella è pretesto per riflettere. Perché certa “leggerezza” tanto leggera non è.
“Che cosa ti spinge a vivere? Perché non ti ammazzi? Perché si riesce a sopportare tutto? Che cosa te lo fa sopportare?
Potevo rispondere a una domanda del genere? No. Sì. Forse… Supponevo, vagamente, che fosse per una sorta di equilibrio, un complesso di tensioni. Si fa la cosa che viene dopo nell’elenco. Un pasto da consumare. Il capitolo undici da scrivere. Il telefono che suona. Si esce in taxi, diretti in un posto qualunque. Il proprio lavoro. I divertimenti. La gente. I libri. Le cose che si possono comperare nei negozi. C’è sempre qualche cosa di nuovo. Deve esserci. Diversamente, l’equilibrio verrebbe interrotto, la tensione spezzata.”
“La morte, bramata, temuta. Il sonno, tanto desiderato. Il terrore del sopraggiungere del sonno. La morte. La guerra. La vasta città addormentata, destinata alle bombe. Il rombo degli aeroplani incursori. Le batterie contraeree. Le urla. Le case sbriciolate. La morte universale. La mia morte. La morte del mondo visto, conosciuto, assaporato, tangibile. La morte col suo esercito di paure. Non le paure che tutti conoscono, le paure cui si fa pubblicità, ma quelle più terribili: le paure segrete dell’infanzia. Paura del tuffo dal trampolino, del cane del fattore e del cavallino del parroco, paura degli armadi, dei corridoi scuri, paura di spaccarsi un’unghia con un taglierino. E, al culmine, la più indicibilmente temibile, la paura prima: quella di aver paura.
[…]
Forse avrei potuto volgermi a Bergmann e chiedergli: «Chi sei? E io, chi sono? Che cosa facciamo qui?». Ma gli attori non possono rivolgersi domande simili durante lo spettacolo.”

 Log in with Facebook
Log in with Facebook